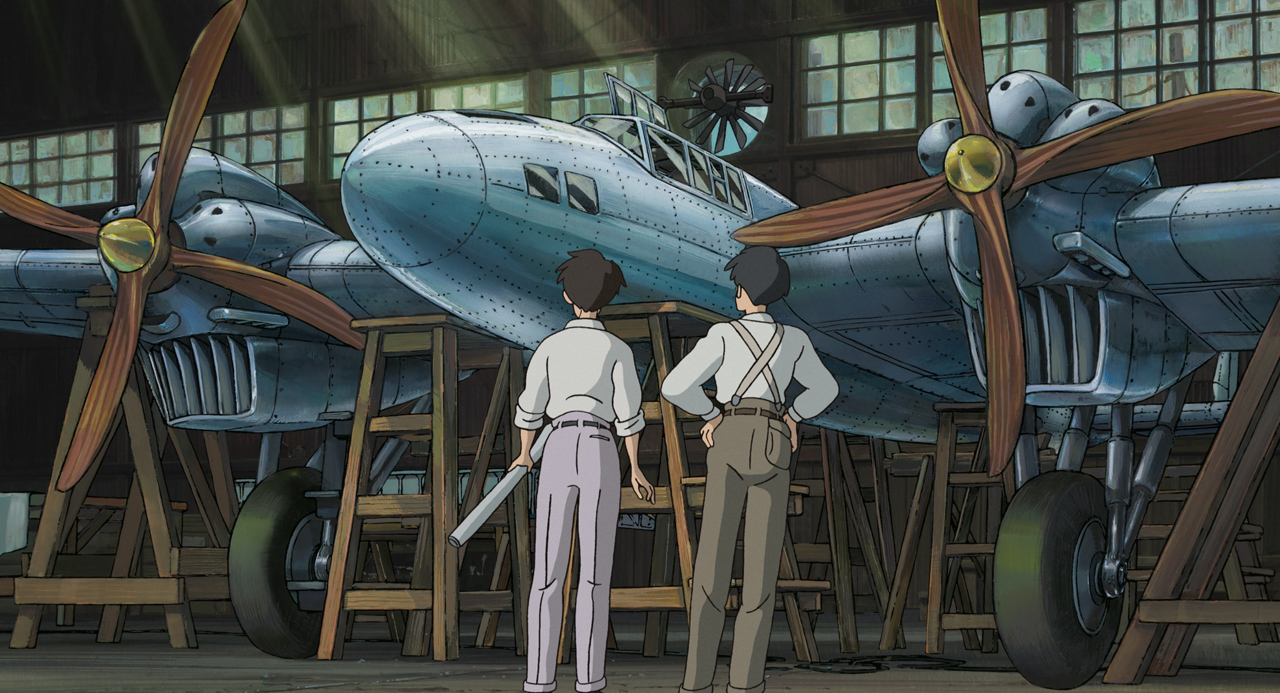Regia: Blake Edwards
Cast: Peter Sellers (Hrundi V. Bakshi), Claudine Longet (Michèle Monet), Jean Carson (Nanny), Marge Champion (Rosalind Dunphy), Steve Franken (Levinson), Buddy Lester (Davey Kane)
Sceneggiatura: Blake Edwards, Tom Waldman, Frank Waldman
Fotografia: Lucien Ballard
Montaggio: Ralph Winters
Paese/Anno: USA/1968
Distribuzione: Dear Film
Genere: Commedia/Demenziale
Sinossi: Hrundi V. Bakshi è un indiano che sbarca il lunario tentando di fare la comparsa nei film di Hollywood. È, tuttavia, molto imbranato e distratto, per questo, malgrado l’impegno, nella maggior parte dei casi i suoi sforzi di apparire sempre all’altezza della situazione sulla scena sfociano in disastri ai limiti dell’assurdo. Dopo che la sua disattenzione ha messo a repentaglio la complessa sequenza di un kolossal, il regista del film chiama il produttore per far cacciare definitivamente l’attore dagli studios. Per un errore, tuttavia, la segretaria inserisce invece il protagonista nella lista degli invitati ad un prestigioso party che si terrà di lì a breve proprio nella lussuosa villa del produttore. Bakshi parteciperà alla festa ma, ingenuo e goffo, si sentirà come un pesce fuor d’acqua. Incapace di porre un freno alla sua sbadataggine il protagonista darà vita, durante il party, alle situazioni più assurde e a gag che manderanno in subbuglio l’intero ricevimento. Durante la serata, tuttavia, conoscerà la giovane Michèle Monet, attrice esordiente di origine francese accompagnata alla festa dal produttore. I due, consapevoli di avere poco o nulla in comune con gli altri invitati del party proveranno una simpatia reciproca e finiranno per far fallire completamente la festa, aiutati, anche, dai figli ribelli del produttore.
Recensione: (di Fabio Fulfaro, da SentieriSelvaggi.it)
Nella tradizione della commedia americana Hollywood Party è un prodotto atipico che mette insieme diverse tendenze: il cinema muto di Keaton e Chaplin, la comicità surreale di Jacques Tati, la struttura slapstick di certe opere di inizio anni ’60 (Il mattatore di Hollywood di Jerry Lewis del 1961, Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo di Stanley Kramer del 1963) e il richiamo alla fumettistica anni cinquanta (Mr Magoo è l’esempio più calzante).
Blake Edwards prende come modello la leggerezza de La Pantera Rosa (1963) e Uno sparo nel buio (1964), e grazie alla performance fisico-mimica di un Peter Sellers in stato di grazia, costruisce una variante comica anomala dall’alto contenuto sovversivo. Il protagonista, l’attore indiano Hrundi V. Bakshi (Sellers), è un’evoluzione in senso politico della figura dell’ispettore Clouseau con cui condivide l’esilarante caratteristica di trovarsi sempre al posto sbagliato nel momento sbagliato. Bakshi possiede un grado di autocoscienza e rispetto verso il prossimo che lo pongono al di fuori sia delle strutture di potere che delle istanze rivoluzionarie sessantottine. Sellers cura ogni movimento in funzione di questa apparente sottomissione, unisce le mani in segno di preghiera, china il capo, chiede perennemente scusa, blatera proverbi insensati (“Saggezza è compagna di vecchiaia, ma il cuore di fanciullo è puro…”), risponde alla minaccia di essere cacciato dal mondo del cinema con una frase leggendaria (“Posso almeno fare televisione?”).
L’opera di distruzione di Bakshi inizia in esterni con il sabotaggio di un set che sembra essere la parodia della espansione coloniale inglese in India (il film omaggiato è Gunga Din del 1939) per proseguire in interni alla festa del produttore in una villa ultra tecnologica attraversata da torrenti artificiali e fontane barocche. Qui, in una serie concatenata di gag che alternano fasi veloci a segmenti più lenti, si scatena la furia devastatrice di Peter Sellers che coinvolge un po’ tutti: vecchie svampite, registi col parrucchino così stolidi da non riconoscerlo, camerieri ubriachi, cowboy atletici accompagnati dalla ninfetta di turno, produttori con il terrore dei comunisti (“Arrivano i russi!”), giovani hippies che portano un elefante color arcobaleno dentro le stanze dell’alta borghesia californiana. Il tutto amplificato da una fotografia iper-cromatica e dalle musiche di Henry Mancini che guidano la jam session verso l’apoteosi finale da cartone animato.
Il film diventa così un musical folle che celebra l’innamoramento di Bakshi per la giovane francese Michèle Monet (Claudine Longet) mentre tutta Hollywood va implodendo per inevitabile autodistruzione: Sellers-Bakshi dà solo la prima spallata, il resto crolla da sé.
Tra le scene da ricordare quella della cena (ripresa dal film Lady Eva del 1941) e il momento magico in cui Michèle suona alla chitarra Nothing to Lose di Henry Mancini sul modello di Moon River strimpellata da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany (1961). Nonostante problemi di pressione vescicale, Bakshi rimane stregato dalla voce della ragazza che sembra cercarlo con lo sguardo per salvarsi dal branco di lupi che le sbava attorno. Il sentimento nascente tra i due sembra una forza anarchica che scardina la messa in scena di un universo tanto colorato quanto fasullo, capovolge un monumento di plastica la cui ridondanza nasconde il sottovuoto spinto (viene in mente la prevalenza del cretino in Zoolander). Paolo Villaggio si ispirerà a Bakshi per disegnare il suo Fantozzi (il tormentone del cameriere, il pollo che finisce sulla parrucca di una invitata) e anche Mr Bean sembra emulare le atroci gesta dell’indiano (la profanazione di un Whistler fa il paio con lo sfregio di uno Chagall).
Blake Edwards segue con la macchina da presa ogni singolo cambiamento espressivo di Peter Sellers che spesso improvvisa al di fuori della sceneggiatura: il risultato è un One Man Show in cui la vis comica nasce principalmente dalla discordanza tra il soggetto e l’ambiente, tra l’umano e il meccanico, tra la semplicità e la complessità; solo raramente ci si affida alla verve di una singola battuta o al colpo basso volgare. Il mondo del cinema sembra non cogliere l’elefante nella propria stanza: si continua a ballare e suonare mentre la casa è sommersa dalla schiuma e l’acqua ha allagato tutti gli ambienti. In un universo spettacolare tutto teso all’apparire, un piccolo uomo, che non si vergogna a mostrare la propria diversità, assume una valenza rivoluzionaria, più delle mode e degli status-symbol americani: in questo contrasto sta l’esplosivo potere eversivo di Hollywood Party.
Approfondimenti:
La Satira Antiborghese
Hollywood Party è un film giocoso a partire dal genere, volutamente lasciato sfumare a cavallo tra la satira del jet set hollywoodiano ed una più ampia critica all’ideologia e alla forma mentis borghese. A colpire è però soprattutto l’atteggiamento, attraverso cui Blake Edwards racconta queste figurine ambiziose ma anche arriviste, vuote, tediate da un’esistenza priva di veri stimoli, desiderosi unicamente di conservare il loro posto al sole il più a lungo possibile. Non c’è ferocia, infatti, nello sguardo di Edwards, che demanda all’atteggiamento ingenuo, gentile e soprattutto ai gesti del suo protagonista il compito di raccontare le asperità di una classe sociale a cui basta un imprevisto, un contrattempo grottesco, per vedere infrangersi tutte le convenzioni su cui hanno fondato il rapporto con l’altro fino a quel momento. Ma proprio per questo Hollywood Party stringe un rapporto tutto particolare con altri prodotti che si muovono sullo stesso orizzonte tematico. Edwards non racconta Hollywood con il disincanto di Fitzgerald in Gli Ultimi Fuochi, storia dell’ascesa e della crisi di un produttore hollywoodiano ispirato al Tycoon Irving Thalberg, ma non ha neanche il cinismo de Il Giorno Della Locusta, cupo film di John Schlesinger sul lato oscuro del jet set, che si chiude quasi ribaltando il caos giocoso dell’ultimo atto di Hollywood Party, raccontando una rissa in cui muore uno dei protagonisti e che poi sfocia in una vera e propria rivolta urbana che mette a ferro e fuoco Los Angeles. Forse il prodotto più vicino allo spirito di Hollywood Party è il successivo SOB, sempre di Edwards, in cui un produttore, dopo un sonoro flop decide di rigirare il suo film, inizialmente pensato come prodotto per famiglie, ripensandolo da zero come prodotto pornografico.
Ma Hollywood Party fatica a trovare posto anche nell’immaginario satirico borghese. Edwards si è ispirato dichiaratamente a La Notte, alla fatigue degli intellettuali ritratti da Antonioni (ma dal film mutua anche lo sviluppo all’interno di un appartamento signorile) ma rifiuta evidentemente la malinconia esistenziale di cui si carica il film, così come tiene a distanza l’aggressività di certa satira bunueliana (pensiamo ad esempio a L’angelo sterminatore). Colpisce inoltre notare, a latere, come oggi l’ironia antiborghese qui portata in primo piano da Edwards abbia finito spesso per smaterializzarsi, ibridandosi con altri generi (pensiamo ad un film come Parasite, che muta all’improvviso il suo passo grottesco in un finale da puro action movie) e sopravviva più o meno in purezza in un prodotto emblematico del presente come la seconda stagione della serie The White Lotus, che forse, non a caso, cita più o meno apertamente moltissimi stilemi del cinema italiano degli anni sessanta, spingendosi a giocare apertamente con l’immaginario evocato proprio da Antonioni ne l’Avventura.
L’identità e lo svelamento
Legatissimo al macrogenere della satira borghese c’è un tema centrale su cui si regge il film di Edward: quello della maschera e del conseguente svelamento della verità al di là di qualsiasi costrutto sociale. Forse non a caso Edwards fa interpretare al suo attore feticcio un personaggio che è già una maschera di per sé. Ma Hollywood Party va oltre. Sviluppa l’elemento comico a partire dall’alterità del protagonista rispetto agli spazi della festa, ma tratta Sellers come un vero e proprio detonatore ideologico. Basta in effetti il suo agire in scena per portare alla luce tutto il malcelato egoismo degli astanti, la loro superficialità, il loro malcelato razzismo, che esplodono coadiuvati dalla sicumera dei presenti, convinti che il loro atteggiamento non venga notato da un protagonista considerato ignorante.
Da questo punto di vista Hollywood Party dialoga con un cinema ricco e sfaccettato che ha proprio al suo centro lo svelamento della reale natura degli individui sulla scena, spesso stimolata da situazioni, che lasciano cadere i costrutti artificiosi imposti dalla loro condizione sociale. Pensiamo ad esempio a cosa accade nel classico Il Conte Max, di Giorgio Bianchi, con Vittorio De Sica ed Alberto Sordi. Nel film l’edicolante Alberto sogna di entrare nel mondo della nobiltà ed improvvisamente ci riesce, aiutato dall’amico aristocratico Max Orsini Varaldo. Per amore sarà però costretto a scegliere quale delle due vite assecondare, quella nobiliare o quella popolare. Opterà, alla fine, per abbandonare l’aristocrazia, proprio quando scoprirà il modo arrogante in cui i nobili trattano la popolana da lui amata.
Nel cinema europeo particolarmente affascinante è l’esempio offerto da Ruben Ostlund, che ha posto al centro dei suoi progetti più interessanti proprio il cinico svelamento dei meccanismi inceppati di intere pratiche sociali. In Forza Maggiore, ad esempio, basta il pericolo improvviso di una valanga poi rientrato quasi immediatamente per mostrare sulla scena le priorità di un padre molto più legato al lavoro che alla sua famiglia e innescare una serie di dinamiche che finiranno per raccontare l’inesorabile crisi di coppia. Ancora, il successivo The Square ha il suo apice nel momento in cui un performer interrompe una cena di gala e mette a disagio gli eleganti borghesi presenti all’evento. Per ultimo vale la pena citare l’affascinante Sorry To Bother You, che prende la dinamica dello svelamento, la ribalta e la connota con una riflessione sulla blackness contemporanea. Protagonista del film di Boots Riley è Cash, un impiegato del call center della Regalview afroamericano che tuttavia diventa uno dei televenditori di maggior successo dell’azienda quando inizia a usare la sua particolare “voce da bianco”. Sempre più in vista tra i ranghi di un’azienda che tuttavia persegue i suoi obiettivi anche con metodi poco etici, Cash scoprirà i lati oscuri della Regalview ma sarà invitato a diventarne mediatore sindacale, per contenere le ingerenze dei lavoratori.
Il Destino della slapstick
Al di là delle tematiche su cui finisce per insistere, Hollywood Party fa parte dell’ampio sottogenere della commedia denominata slapstick, i cui prodotti si caratterizzano per una comicità tutta retta dalla fisicità dell’attore e per un’importanza di primo piano rivolta a gag grottesche che attraverso la ripetizione di dinamiche, il gioco con le proporzioni, gli oggetti, le situazioni, spingono l’umorismo verso il parossismo. Ma Hollywood Party fa un discorso particolare in questo senso. Il lavoro di Edwards è infatti un dichiarato tributo ad un modo di intendere la comicità che proprio in quegli anni aveva perso forza ma che, soprattutto tra gli anni trenta e sessante fu popolarissimo. Così è particolarmente interessante ricostruire in primo luogo tutti i riferimenti alla slapstick che Hollywood Party ripesca e reimmette nel flusso narrativo, dallo sguardo gentile e dalla prossemica contenuta di Buster Keaton, base per la caratterizzazione scenica di Bakshi, al cinema sui generis di Jacques Tati, di cui Edwards riusa non solo situazioni (la struttura narrativa ricorda quella di Tempo di divertimento, capolavoro del comico francese del 1967) ma anche interi props scenici (con la villa iper-tecnologica che diventa vero e proprio co protagonista delle gag di Sellers come in Mon Oncle di Tati).
Ma ci si potrebbe anche chiedere se e come è evoluta la slapstick dopo il boom di popolarità di Hollywood party e, soprattutto, qual è il suo destino, la sua condizione di salute, nello spazio dell’intrattenimento contemporaneo. Curiosamente, in effetti, la raffinatezza di scrittura di Hollywood Party non ha fatto scuola nel cinema coevo che a partire dagli anni ottanta ha ripreso a muoversi nella scia di certa slapstick ma ha conservato del sottogenere soprattutto la fascinazione per l’elemento demenziale dell’azione scenica. Pensiamo ad esempio alle parodie del trio Zucker/Abrahams/Zucker (dall’Aereo Più Pazzo del Mondo ad Hot Shots) ma anche ad un franchise come quello di Scuola di Polizia. Erede, in senso lato delle atmosfere di Hollywood Party rimane forse, soprattutto in alcuni passaggi (emblematico che anche qui il centro narrativo passi per un party mandato in crisi da uno dei personaggi) lo straordinario Animal House di John Landis, tutto inscritto nel corpo e nelle gag del mattatore John Belushi. Per ritrovare un’idea di slapstick più definita e personale bisognerà attendere gli anni novanta, con il Mr Bean di Rowan Atkinson ma sarà una resurrezione solo temporanea. Ora, in effetti, i tratti della slapstick hanno finito per smaterializzarsi, riemergendo solo per rafforzare o sottolineare passaggi di film che in realtà guardano quel concetto di comedy solo da lontano. Vengono allora in mente certi passaggi demenziali di Thor – Love And Thunder, diretto da Taiki Waititi (il cui JoJo Rabbit forse è addirittura più vicino alle atmosfere che qui stiamo sfiorando) ma anche l’interessante film d’animazione Luck, che nel raccontare l’effetto della sfortuna con cui la giovane protagonista si confronta da sempre utilizza proprio il linguaggio velocissimo e puntellato di idee della slapstick.